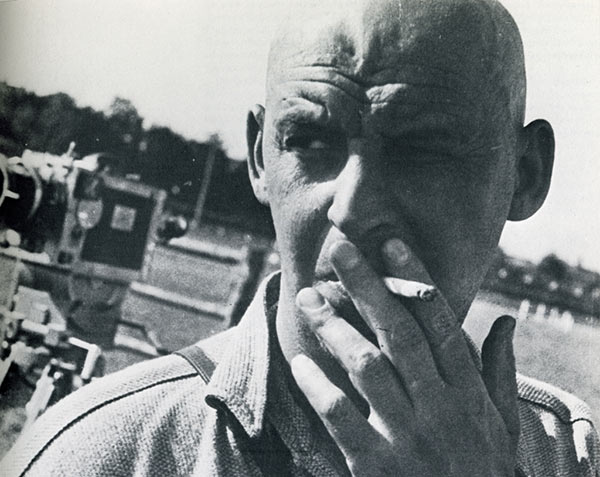Cavacchioli Enrico
Nato a Pozzallo (Ragusa), da Vincenzo e da Silvia Federici il 15 marzo 1885, giovanissimo si stabilì a Milano, prendendo parte attiva alla vita culturale come giornalista e poeta. Le sue prime esperienze poetiche echeggiarono i modi dannunziani allora in voga, per passare in un secondo tempo a toni crepuscolari. Aderì subito al movimento futurista, attirato soprattutto dal potenziale di concreta rivolta contro la tradizione e l’accademia, e fu uno dei militanti più in vista di questa corrente d’avanguardia, con una prepotente immediatezza di sentimenti e un fascino quasi barbaro, pure muovendosi per certi aspetti ancora nel solco della tradizione.
Fu tra i firmatari del Manifesto, pubblicato a Parigi nel 1909. È citato tra i “poeti incendiari” dello schieramento futurista del secondo manifesto programmatico dei movimento: Uccidiamo il chiaro di luna! Sottoscrisse i manifestini Contro Venezia Passatista che l’8 luglio 1910, in gran copia, furono lanciati dalla torre dell’orologio della città; partecipò alle tumultuose “serate futuriste” che immancabilmente si concludevano con risse e tafferugli, e fu presente al processo per oltraggio al pudore intentato contro il romanzo di T. Marinetti, Mafarka il futurista.
Fu il momento dei suoi esordi letterari sulla rivista di Marinetti Poesia e, nelle edizioni omonime, della raccolta di poemetti e liriche L’incubo velato (Milano 1906) con cui vinse il secondo concorso di “poesia”; poi fu la volta di Le ranocchie turchine (ibid. 1908), e infine della raccolta futurista Cavalcando il sole (ibid. 1914). II.C. però risente ancora di moduli dannunziani e crepuscolari, e soprattutto, dal punto di vista tecnico-formale, poche volte si avvale delle innovazioni futuriste della distruzione della sintassi e delle parole in libertà, e non manca di usare la metrica tradizionale e le tecniche versificatorie consuete. Un’evasione dalla tradizione è, tuttavia, palese e domina “una fantasia che è una feerica anarchia” (Palmieri).
Col 1914 il C. si venne distaccando dal futurismo. Collaborò a numerose riviste con novelle e articoli, fu redattore de La Stampa di Torino e de Il Secolo di Milano, del quale fu anche critico drammatico fino al 1920. Durante la guerra fu corrispondente di vari giornali; diresse poi il settimanale Il Mondo, e per molti anni fu direttore dell’Illustrazione italiana; nel 1920 entrò a far parte del consiglio direttivo della Società degli autori. Fu anche un fecondo collaboratore della rivista di M. Mariani Comoedia, fondata nel 1919, nella quale pubblicò la maggior parte delle sue commedie e di cui divenne direttore dal 1928, succedendo a G. Cantini. Divenne animatore culturale della casa editrice Vitagliano, di cui era stato a Milano uno dei fondatori; nel 1924 ebbe l’incarico di direttore artistico della Piccola Canobbiana di Milano, con Febo Mari direttore tecnico.
Come commediografo il C. aveva già composto nel 1909 Procellaria (rappresentata nello stesso anno a Firenze al teatro Niccolini dalla compagnia Sainati), I corsari (cit. da S. D’Amico in Il teatro italiano, ma di cui non si hanno notizie), e La campana d’argento (in Comoedia, 25 ag. 1920, pp. 5-42), la cui prima, data il 24 apr. 194 all’Olimpia di Milano dalla compagnia Borelli-Piperno con l’attrice Lyda Borelli, si concluse in un catastrofico insuccesso.
Insieme con L. Chiarelli, L. Antonelli, P. Rosso di San Secondo e altri il C. tentò un rinnovamento della scena con un teatro d’avanguardia cosiddetto “grottesco” – dalla definizione che Chiarelli diede della sua commedia La maschera e il volto – che ebbe una breve ma fortunata stagione e i cui antesignani si è voluto rintracciare in R. Lothar, V. Andreev, F. Molnár e certo Pirandello narrativo e drammatico.
Questo teatro si caratterizza per il deciso rifiuto dei valori e dei miti della commedia borghese, in special modo quella praghiana, che vengono sottoposti all’azione corrosiva di un’ironia tragica e grottesca che li stravolge e mette in luce la falsità, l’ipocrisia e il vieto conformismo cui si ispirano. La tematica viene ripresa dal teatro borghese, soprattutto quella triangolare dell’adulterio – marito, moglie, amante – ma per riaffrontarla con intenti dissacratori sotto l’impeto di uno spirito parodico, beffardo e demolitore che fa muovere i personaggi come fantocci, svuotati d’anima e resi ridicoli. Nel C. però l’ambizione a realizzare un teatro nuovo si risolve in una modernità tutta esteriore e artificiosa; in sostanza ci si limita ad “adornare di aggeggi futuristi il vecchio dramma borghese” (Antonini), sebbene non manchi una certa originalità d’impostazione che spesso si smarrisce in un groviglio di simboli e allegorie.
Il frutto più maturo di questo teatro, “l’opera indubbiamente più armonica nella sua struttura, più chiara nella sua poetica” (Livio) fu L’uccello del paradiso (Milano 1920), confessione in 3 atti, rappresentata il 19 marzo 1919 al teatro Carignano di Torino, con un buon successo, dalla compagnia di V. Talli, con gli interpreti M. Melato, M. Valsecchi, A. Betrone, A. Marcacci, E. Olivieri, S. Tofano.
In questa commedia, “frutto di un’arte ultrariflessa, materiata di autocritica” (D’Amico, Cronache del teatro, I, p. 147), lo scrittore riproponeva una situazione drammatica prettamente borghese – l’amore di due donne, madre e figlia, per lo stesso uomo – in cui la novità consisteva nell’introduzione, a partire dal secondo atto, di un “personaggio-astrazione, irreale, filosofico”, come spiegava il C. nella didascalia, indicato come Lui e che si autodefiniva “il senso dell’opportunità”: una sorta di deus ex machina, di coscienza dei personaggi, di burattinaio che calava sul palcoscenico insieme ai suoi burattini e palesemente ne teneva le fila, abbandonandosi a volte, per épater le bourgeois, a complicate elucubrazioni pseudofilosofiche, con imprestiti evidenti dagli irrazionalisti allora in voga.
In Quella che t’assomiglia (in Comoedia, 25 nov- 1919, pp. 5-43; e Milano 1920), rappresentata la prima volta il 26 nov. 1919 all’Alfieri di Torino dalla compagnia Di Lorenzo-Falconi, con T. Di Lorenzo, A. Falconi, R. Lupi, L. Cimara, D. Migliari, il C. riprendeva una delle situazioni più trite del repertorio borghese – un’adultera indecisa tra l’amore per il marito, ritornato dalla guerra cieco e paralitico, e l’amante – andando ancora più oltre nelle innovazioni tecnico-formali, in parte derivate dal futurismo. Nel C. però “il futurismo appare nella sua forma letteraria essenziale, come un travestimento, nell’epoca delle macchine e della grande industria moderna, del romanticismo truculento e grandiosamente cretino del 1848” (Gramsci), e certa originalità esteriore a base di donne dai capelli verdi, di uomini dalle ruote al posto degli occhi, di fantocci somiglianti ai personaggi che si esprimono risulta artificiosa e poco convincente. Nella Danza del ventre (in Comoedia, 20 ottobre 1921, pp. 1-29), rappresentata a Milano al teatro Manzoni nel febbr. 1921 dalla comp. Borelli (Alda)-Carminati, tentava di esprimere il conflitto tutto romantico tra realtà e illusione, Leitmotiv del suo teatro. L’eunuco Nadir, Pupa e Arlecchino non sono che puri simboli, l’azione scenica è resa meccanica, ma alla fine il C. non se la sentiva più d’insistere con l’ironia, fino a distruggere i suoi fantocci, deformazione scenica dei personaggi, e così “li prende sul serio e piange con essi” (Tilgher), ricadendo nei tópoi più compromessi del teatro romantico tradizionale e cedendo al sentimentalismo e al patetico. Compose poi la fiaba grottesca Pinocchio innamorato, in 3 atti, in collaborazione con A. Rossato (in Comoedia, 5 febbraio 1922, pp. 113-145), la cui prima al teatro Carignano di Torino il 2 febbr. 1922, con la compagnia Niccodemi, fu il fiasco più fragoroso di tutti i lavori del C. messi in scena. Seguirono i 4 atti de Il cammello (in Comoedia, 15 aprile 1921, pp. 1336), rappresentato al teatro Niccolini dalla compagnia Talli nell’aprile del 1923, e Allegoria di primavera (in Comoedia, 1º settembre 1921 pp. 15-31), rappresentata al teatro Filodrammatico di Milano nel maggio 1923 dalla compagnia di A. Borelli. In Pierrot impiegato del lotto (in Comoedia, 20 apr. 1926, pp. 3-31) rappresentata il 7 ottobre 1925 a Milano dalla compagnia Ilari, con F. Mari e G. Chiantoni, il nucleo centrale è ancora il dissidio tra il sogno e la realtà, simboleggiata da Luba, una principessa russa volubile, crudele e sensuale. La vicenda è ancora legata a schemi della commedia romantica d’appendice, anche se il C. tenta di camuffarli con i suoi artifici e le sue trovate tecniche, ma in definitiva “non supera il livello dell’operetta, ma di un’operetta afosa sinistra spettrale” (Tilgher). Si ricordano inoltre: La corte dei miracoli (in Il Dramma, 1º giugno 1928, pp. 5-32); Il cerchio della morte (ibid., 1º maggio 1930, pp. 5-29) alla cui prima, nel mese di gennaio del 1930, con la compagnia Za-bum, si misero in scena addirittura acrobati di professione e un leone vero; L’oasi (in Scenario, 1935, n. 11; e Milano 1936) rappresentata a San Remo dalla compagnia Ricci-Adani il 18 nov. 1935; infine Le stelle nel pozzo (in Scenario, 15 apr. 1943, pp. 125-136) rappr. a Milano al teatro Nuovo dalla compagnia Ruggeri il 2 marzo del 1942.
Come romanziere compose Vamp (Milano 1930), in cui evidente è l’influenza di D’Annunzio e Guido da Verona, e Serenata celeste (ibid. 1932); ma il C. “narratore non vale, neanche lontanamente, il lirico e il drammaturgo” (Jacobbi). Fu autore inoltre di numerosi libretti per opera: Zingari (Milano 1912), tratto da Puškin, in collaborazione con G. Emanuel, per la musica di R. Leoncavallo; Marken, per la musica di G. Bucceri; I fuochi di S. Giovanni, tratto da H. Sudermann, e Il donzello, entrambi per la musica di E. Camussi; in collaborazione con L. Illica Avemmaria e la riduzione di Vincenzella di L. Bovio, per la musica di P. La Rotella. Nel secondo dopoguerra, per qualche anno fu direttore della Gazzetta di Parma.
Morì a Milano il 4 genn. 1954.
Alcune poesie di Enrico Cavacchioli La porta del lupanare Malinconiche nostalgie di serenate, che salgono i viottoli della città come il profumo del caprifoglio: a fiotti scampanella il richiamo fresco dei gelsomini che zampillano da una inferriata spinosa, e l'ululato di un cane vagabondo accompagna la chitarra. Conosco le creature che vorrebbero morire in una sosta del canto, quando si cercano gli accordi. Dalle finestre aperte, ascoltano palpitare la propria insonnia come se avessero il cuore vivo nel palmo della mano, e quando il canto lontano oscilla come il nido sul ramo frustato dal vento, si che la voce sembra cambiarsi in un singhiozzo, s'abbatton con la bocca sul guancial troppo bianco! Che cosa vorrebbero dire le labbra troppo rosse in quel profumo di tisi che sale dai giardini assonnati, tra il chiocco1io delle vasche esauste e moribonde? La chitarrata naviga il cielo come un oceano. e s'inghirlanda delle ultime stelle d'Agosto. Che cosa vorrebbero udire da quelle bocche nascoste che valican le nubi cantando nella luna e si posano a tratti come tortore stanche, le creature smarrite nel desiderio della morte? Anche la chitarrata muore, lontana e nostalgica come esalando un suo respiro pudico, fra case bianche ed orti interminabili. E mentre voi, creature che vorreste morire nel singulto mordente degli accordi strappati, vi abbandonate a un triste singhiozzar taciturno, i suonatori sghignazzano, nascosti nella porta del lupanare: che veglia nel vicolo notturno. (da "Cavalcando il sole") Danza della pazzia Se i guardiani taciturni che vegliano la nostra pazzia si addormenteranno ripiegando sulla propria stanchezza la testa calva, dagli occhi lucidi e stravolti, o compagni dei miti sogni celesti, noi danzeremo una danza infinita: prima di morire. E sarà l'ultima ebbrezza quella che canterà a martello nelle tempie sensibili i riti inesprimibili della ragione! Gettiamo disordinatamente in un cake-walke fantastico le nostre gambe per aria! Che facciano la ruota questi pavoni maledetti, in un giardino incendiato all'ombra di un grande albero secolare! Agitiamoci come i risuonanti zoccoli marinareschi in piedi microscopici di fanciulle sognanti: nel vano della finestra, incuriosita, una fanciulla fila all'arcolaio d'oro, e la matassa s'annoda di stelle, ed il gomitolo, alfine, si chiude: o bel cuore che abbia diffuso il suo sogno in un delirio notturno! Io so il vostro passo ginnastico e cadenzato simile a quello del mare, che dalla riva stridente corre a raggiungere il sole che s'affonda nell'acqua; ad ogni istante un baleno sanguigno lo punge; e l'ombra della montagna, da terra, lo insegue col fiotto. A poco a poco, al passo isolato s'aggiunge l'irrequieto ansimare delle onde tumultuose, ma il sole fugge a ritroso, scivola sulla maretta, e speronando il cielo che lo lascia passare, entra fra due cortine di nubi d'oltre mare come in una tranquilla alcova violetta. Se danzeremo, o compagni dei miei sogni celesti prima che si risveglino i guardiani atterriti, noi troveremo pure un canto: che allunghi su di noi l'inno tranquillo della nostra fine. Ma ci parrà la voce straniera, sopraggiunta dall' invisibile regno della Ragione lontana, come la campana che annunzia a tre rintocchi nel crepuscolo insonne, l'ora fedele della morte. Ogni musica lenta, troppo lenta, sarà per questa danza scapigliata, ed ogni movimento, troppo lento, qualunque febbre lo culli del suo calor tropicale. Ma se i vostri occhi splenderanno, a notte, dell'importuna saggezza di una follia più feroce, quelle piccole fiamme soltanto vedranno gli uomini ragionevoli navigare nel buio: lucciole a coppie, in cerca d'un riposo. E la danza suprema della notte che trema - e s'addormenta svanirà con un passo elegiaco, quasi che i nostri corpi invisibili volessero finire in una sinfonia di carezze. …Tutto un giardino azzurro: mormorare di foglie, un mandolino che si lamenta, suona in un chiaro di luna artificiale, e l'anima ci fa male, tanto male perchè la nostra pazzia vede più della Ragione che ci abbandona! (da "Cavalcando il sole") Cani senza padrone e senza laccio. Cani vagabondi, nel rumore della città sconfinata, cani senza padrone e senza laccio, cari ai "notturni" dei poeti, io v'ho sentito nelle chiare serenate d'Aprile abbaiare alla luna, in un lugubre strazio, il ritornello di pianto dalla gola affamata. Era il cielo più profondo e luminoso di lontananza: tutto palpitava nella diafana stanchezza della notte, se il vento tiepido impregnava i roseti e le siepi, e i messaggi dei mondi valicavano gli spazî, per la via lattea, drappeggiata orifiamma. Solo il miserabile armato del grimaldello spiava il vostro spasimo sbadigliante nella tenebra, e correva il selciato pulito dalla luna. Ma dietro al passo elastico, balzava a perdifiato la vostra corsa ansimante. E la via ne risonava ad un tratto, strappata nella tenebra dall'ululare irascibile. L 'alba vi ritrovava, così, nella sua nudità, bagnati dal suo brivido, dalla testa alla coda, e le stelle morivano nei vostri occhi assonnati, se, il vento le portava in un'altra notte lontana come uno sciame di lucciole palpitanti nella grigia meraviglia antelucana… Cercheremo un paese rosso per dormire la siesta quando la pancia è gonfia di vento e le pulci ci ballano addosso una tarantella molesta! Spolperemo la sanguigna frangia d'una carogna bagnata di sole! È giusto che la divoriamo, se il sole la mangia, in un prato livido di viole! Troveremo una cagnetta domestica profumata come una cocotte perchè inghirlandi la nostra avventura contro natura, sapendo la curiosità della nostra libera brutalità! E pisceremo di corsa, passando all'ombra di qualche tabernacolo: rispettiamo troppo la religione benchè siamo cani senza laccio e senza padrone!… Era il cielo più profondo e luminoso di lontananza e l'Aprile bruciava nell'incensiere del mondo il profumo della sua giovinezza ammalata e ribelle: un fantasma di donna con un diadema di stelle. (da "Cavalcando il sole")